Una delle grandi domande con cui ogni politica rivoluzionaria si scontra nel momento in cui si interfaccia col mondo è: perché le persone non si ribellano? Ovvero, data la situazione disperata in cui si trovano, i soprusi che subiscono e la mancanza di soluzioni serie, perché le persone dominate non si decidono una volta per tutte a fare la rivoluzione?
Lo spettro di questa domanda aleggia sopra qualsiasi tentativo di mobilitazione, specie nel mondo contemporaneo in cui, dopo almeno trent’anni di neoliberismo imperante (ovvero trent’anni in cui i ricchi hanno vinto), i motivi per non ribellarsi sembrano davvero pochi. Ma d’altronde, se le persone si mobilitassero da sé non servirebbe neanche che alcunɜ di noi si impegnassero a smuoverle… Ed ecco che questa domanda senza risposta diventa un’ossessione, che in qualche caso porta all’avanguardismo marxista-leninista (“le persone non si possono organizzare da sé, serviamo noi a dire loro cosa fare”) o al disfattismo misantropo (“non c’è niente da fare, la gente non vuole migliorare la propria condizione”).
Ovviamente non saremo noi a dare una risposta a questo problema. Ma tramite Il dominio e l’arte della resistenza di James C. Scott possiamo quantomeno aggiungere un tassello fondamentale a questa considerazione, che ci può indicare qualche via d’uscita da questo cul-de-sac.
Famoso principalmente come geografo critico (vedi Lo sguardo dello Stato), Scott è un antropologo anarchico che, come altrɜ suɜ colleghɜ libertariɜ, ha cercato di capire meglio il meccanismo del dominio, ovvero delle condizioni in cui le differenze di potere sono istituzionalizzate. Per farlo ha analizzato culture di varie epoche e luoghi, cercando delle forme comuni di resistenza alle varie forme di ingiustizia subita.
Per seguirlo, dobbiamo però innanzitutto guardare alle persone con uno sguardo nuovo, uno sguardo antropologico (giustamente). Una comprensione dell’umano che è situata e non giudicante, che cerca di capire i significati intrinsechi a una cultura senza chiedersi se “hanno senso”, se sono “buoni o cattivi”, ma sforzandosi di creare un ponte tra la propria cultura e quella altrui. Per intenderci, quello sguardo che di fronte a una persona piccola che gioca sotto un tavolo invece che sopra di esso ci porta a pensare che, vista la sua altezza, il tavolo ha nella sua esperienza molto più senso come soffitto che come superficie (e invece il contrario per noi persone adulte). Uno sguardo che potremmo definire anche molto queer, nella misura in cui può rendere i nostri assunti acritici strani per riflesso.
Interiorizzata questa visione, possiamo affrontare il primo punto che spesso ci assilla nel pensare al dominio: il fatto che le persone lo accettino a causa di una loro comprensione limitata o erronea o a causa della rassegnazione, due forme di falsa coscienza. Scott distingue
tra una versione «forte» e una «debole» della falsa coscienza. Quella forte asserisce che l’ideologia dominante opera la sua magia attraverso la persuasione dei gruppi subordinati, inducendoli a credere attivamente nei valori che spiegano la loro subordinazione. [… Quella debole] si limita a sostenere che che l’ideologia dominante ottiene l’acquiescenza convincendo i gruppi subordinati che l’assetto sociale in cui si trovano è naturale e inevitabile.
Due convinzioni da cui sembra difficile uscire, e che forse rivediamo con tristezza anche nei molti modi in cui noi stessɜ manchiamo di mobilitarci. Ma, dice Scott, queste convinzioni si basano sul presupposto per cui il canale del potere sia unidirezionale, che l’ideologia dominante venga accolta/subita dallɜ subordinatɜ senza una loro reazione. Un presupposto che, dopo aver guardato un qualsiasi gruppo umano, è impossibile sostenibile con convinzione.
Pensiamo ai casi che ci appaiono più emblematici del dominio ideologico di una classe dominante: le società dove il sovrano è divinizzato o scelto da una divinità. Qui, nota Scott, sia lɜ dominanti sia lɜ dominatɜ credono nell’aspetto divino della figura del sovrano, e talvolta è stato impensabile asserire il contrario. Eppure questo non ha mai impedito che si creassero sollevazioni popolari, spesso proprio perché il sovrano avrebbe dovuto essere divino e quindi avrebbe dovuto mantenere la giustizia nel suo regno — pensiamo ai Tuchini che si oppongono alle angherie dei nobili chiedendo ad Amedeo VII di Savoia di riportare giustizia, o l’opposizione a Riccardo senza terra perché regnante illegittimo. Credere nei valori della classe dominante non impedisce che essi siano usati — più o meno in buona fede — per muovere critiche e agire dissenso verso la propria dominazione. E soprattutto, la Vandea difficilmente avrebbe potuto opporsi al nascente Stato rivoluzionario francese, e i contadini guidati da Watt Tyler nel XIV secolo nulla avrebbero potuto contro l’esercito di Riccardo II: queste rivolte sono avvenute indipendentemente dal fatto che ci fosse qualche possibilità che la rivolta avesse successo, e quindi indipendentemente dal senso di inevitabilità che accompagnava lɜ rivoltosɜ.
Ecco che, come dal titolo, emerge la categoria principe dell’analisi di Scott: la resistenza. Una resistenza continua, carsica (o ctonia se vogliamo), che si esplica in mille forme culturali più o meno esplicite, più o meno giuste (visto che spesso ripropongono la forma di dominazione subita verso gruppi ancora più subordinati), e più o meno capaci di creare alternative concrete al presente. Il punto non diventa quindi capire perché le persone non si oppongono al sistema, ma solo dove esse si oppongono, in quanto ogni forma di potere genera necessariamente una resistenza. Se così non fosse, non sarebbe necessario al potere affermarsi attraverso gesti — simbolici, materiali, violenti — che diventano nuovo terreno di contestazione e quindi nuova necessità di affermare l’ideologia dominante (Foucault docet).
Quest’idea di una resistenza diffusa e onnipresente non è però un concetto ontologico o metafisico. La resistenza lascia dei segni ben precisi che possiamo rinvenire nella Storia e nelle nostre esperienze. Partendo da ciò che è a portata di mano, pensiamo a tutti i piccoli modi in cui rendiamo meno facile un rapporto in cui siamo subordinatɜ: far finta di non aver capito degli ordini, impiegare molto tempo a svolgere azioni semplici, fare quello che vogliamo appena un controllore si dilegua, sparlare alle spalle dei nostri capi con dellɜ colleghɜ, scambiare sguardi ammiccanti quando un nostro superiore si comporta male, non rispettare i patti che ci sono stati estorti, fare lɜ gnorri quando unə nostrə sodale viene sgridatə. Esperienze a cui è facile dare poco peso, ma che dimostrano una tensione costante alla resistenza.
Allargando lo sguardo a gruppi più ampi, la sostanza dei comportamenti non cambia, ma adottiamo categorie capaci di tenere conto di fenomeni sociali. Scott parla di «verbale pubblico», cioè «l’interazione palese tra i subordinati e chi li domina»: la performance comune che si instaura, ad esempio, tra un capo e lɜ suɜ sottopostɜ, in cui questɜ mostrano deferenza nei suoi confronti e lui benevolenza nei loro, indipendentemente dal fatto che ci sia diffidenza od odio reciproco. A questo insieme di gesti e discorsi fa da contraltare il «verbale segreto», cioè
il discorso che ha luogo «dietro le quinte», fuori dall’osservazione diretta di chi detiene il potere. Il verbale segreto è così una derivazione, nel senso che è costituito da quei discorsi, gesti e pratiche fuori scena che confermano, oppure contraddicono, o semplicemente modificano, ciò che appare nel verbale pubblico.
Per rimanere nell’esempio sopra, il verbale segreto contiene l’idea che il nostro capo sia uno sfruttatore incompetente, idea condivisa con altrɜ colleghɜ, ma anche il far cadere la penna alle sei in punto contro la propria immagine di lavoratorɜ indefesso, fino al boicottaggio e al furto (come l’operaio-massa degli operaisti italiani). Tutto questo insieme di performance si oppone e mina le basi della narrazione dominante che mantiene ordinato il rapporto di potere in ufficio. Un insieme di pratiche che emerge in qualsiasi condizione, dalla schiavitù alla governamentalità neoliberale, in modi sempre intelligenti, accorti, artistici (come dal titolo), e che Scott ritrova nelle pratiche sovversive del carnevale, nelle malelingue dei villaggi inglesi, nelle visioni cristiane millenaristiche dellɜ schiavɜ nerɜ negli Stati Uniti, nelle figure culturali delle classi dominate come il trickster… Infine, ma senza addentrarci troppo, verbale pubblico e segreto non sono mai dati una volta per tutte, ma sono sempre in continua relazione. Là dove avanza uno l’altro si difende, ora usando eufemismi e codici, ora stigmatizzando chi si spinge troppo in là.
Riprendendo la domanda iniziale, possiamo quindi dire che come persone rivoluzionarie cadiamo spesso in un errore. Pensiamo che l’unica forma di resistenza sia quel momento, che alle volte avviene, in cui il verbale segreto emerge pubblicamente, in cui si rompe la magia del verbale pubblico e lɜ dominatɜ minacciano direttamente il potere — quello che chiamiamo rivolta, rivoluzione, riot. Questo è un errore per due motivi. Il primo è che così facendo manchiamo di analizzare tutto quell’universo di resistenze che le persone agiscono costantemente, e che seppur non trasformativo di per sé può darci materia e ispirazione per costruire reti di opposizione al dominio più solide ed efficaci. Ricostruire la storia della resistenza al dominio, invece che della sola rivoluzione, moltiplica le pratiche a cui ci possiamo ispirare nella nostra lotta. Il secondo è che in questo modo perdiamo la possibilità di interfacciarci con le forme attualmente agite di resistenza, non riconoscendo il lavoro che pure viene già fatto da tuttɜ lɜ subordinatɜ, interfacciandoci con loro senza capire la loro lingua. Soprattutto nel momento in cui chiediamo di agire conflitti più espliciti, dobbiamo riconoscere ciò che è dovuto, e non pensare che chi non resiste come vorremmo non resista affatto.
Infine, da tutta la visione di Scott emergono secondo noi alcuni punti importanti da tenere a mente per le politiche trasformative, e che vogliamo porre come delle piccole massime.
Capire quali sono i nostri strumenti di resistenza. Non cercare azioni di resistenza nuove e inusuali, ma prendere coscienza della resistenza che già mettiamo in atto e in cui abbiamo già esperienza. Analizzare i modi in cui ci confrontiamo col dominio e chiedersi se possono essere utilizzati in chiave trasformativa: ad esempio, condividendo i modi in cui boicottiamo il nostro lavoro o in cui prendiamo per il culo i nostri governanti.
Non pensare le persone passive. Ogni persona in un sistema di potere ha delle pratiche di resistenza che già utilizza. Invece che proporre modalità molto lontane dalla sua esperienza (ad esempio chiamando a forme di protesta conviviali persone abituate a resistere singolarmente), cercare di familiarizzarsi e capire come chi abbiamo davanti gestisce la sua subordinazione. Nel proporre forme alternative o modifiche alla sua resistenza, partire dalla comprensione e non dal giudizio.
Cercare sempre di imparare dalla resistenza altrui. La resistenza che le persone offrono in un dato spazio è frutto di anni di lavoro collettivo, ed è adattata alle condizioni specifiche di quel contesto. Cercare di agirla insieme e di capirne la logica è d’aiuto a comprendere più a fondo il sistema di dominio in cui ci troviamo e immaginare forme utili a cambiare i rapporti di forza.
Capire che cosa possono offrire le nostre forme di resistenza. Proprio perché tuttɜ agiamo resistenza quotidianamente, siamo anche abituatɜ a ottenere dei risultati, per quanto piccoli. Non siamo sprovvedutɜ rispetto all’efficacia delle forme di lotta che proponiamo o ci vengono proposte. Prendere consapevolezza di questa nostra capacità e non aver paura di ritenere inefficace una forma di resistenza — anche se decidiamo di tentarla lo stesso.
Cercare le forme di resistenza nelle nostre organizzazioni. Uno dei motivi per cui spesso non riusciamo a organizzarci è che supponiamo che le persone (noi compresɜ) parteciperanno volentieri — condizione molto rara per chi vive in un mondo gerarchico e fondato sulla delega. Per creare organizzazioni orizzontali e libere, prestare costante attenzione ai modi in cui noi e lɜ altre opponiamo resistenza alle nostre stesse modalità di organizzazione, e cercare di capire il perché. Creare degli spazi in cui il verbale pubblico («questa associazione è importante e dobbiamo impegnarci») può confrontarsi col verbale segreto («fare associazionismo è una merda») in modo da cambiare la situazione e aprire spazi di trasformazione.
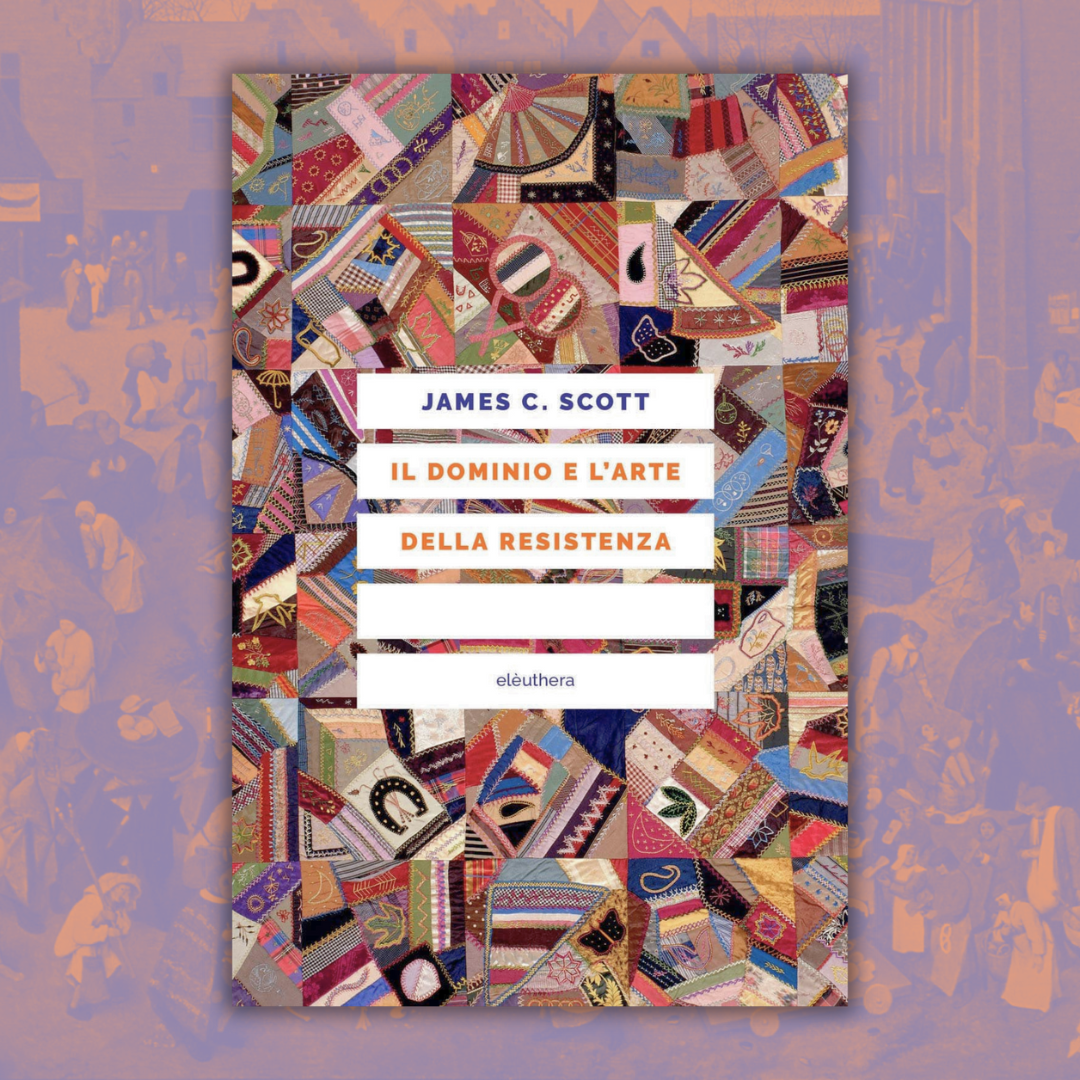
✉️ Ricevi la newsletter
📺 Entra nel canale Telegram
Linkano qui: