Collettivo Contesto
Dissidentificazione [dis.si.den.ti.fi.katˈʦjoːne]
Gesto politico che consiste nel rigettare il ruolo ricoperto.
Es. «la nostra rivoluzione è la d. universale»
In questo articolo:
Per essere chiar3 fin da subito: dissidentificazione è un’immodesta proposta per tradurre in italiano il termine queer.
Una traduzione che non è mai solo una traduzione, ma porta con sé delle connotazioni sue specifiche, capaci di suggerirci direzioni politiche nuove o poco frequentate. Da qui nasce il desiderio di mettere insieme una serie di testi per ragionare sul concetto di dissidentificazione e sullo scarto che inevitabilmente lo separa da queer.
Dissidentificazione nasce dalla mescolanza di due campi semantici: da una parte quello delle barricate e dei riot, della dissidenza e della lotta contro le forze dell’ordine costituito; dall’altra quello decisamente accademico della decostruzione, che incrocia la genealogia foucauldiana e la teoria della performatività. Un campo non si regge senza l’altro. Un terzo ambito, da cui abbiamo deciso di partire, è l’esperienza incarnata.
Due scene
(11 maggio)
Stamane per la prima volta sono stato testimone di quella curiosa pratica ecotopiana nota come critica cooperativa. Mi sono fermato in uno dei piccoli caffè aperti sul davanti, dov’è possibile avere una sana e abbondante colazione. Tavoli stile famiglia, ma è ancora presto e la conversazione frammentaria. Un uomo vicino a me che ha ordinato delle uova strapazzate rompe il silenzio dopo che il cameriere gli ha portato il piatto.
«Guardate qui queste uova» dice, non al cameriere come avrebbe dovuto, ma rivolto a tutti gli avventori. Le mostra perché tutti possano vedere. «Sono troppo asciutte!»
A questo punto, mi aspetto che il cameriere tenti di placare il cliente e di offrirgli un nuovo piatto di uova. Al contrario, sia il cliente sia il cameriere si dirigono verso la cucina, che si trova in vista a un lato della stanza, separata solo da un bancone. (Agli ecotopiani piace poter esaminare gli ingredienti e assistere alla cottura dei cibi. Le loro cucine sono sempre in vista, ed essi osservano i cuochi come da noi s’usa guardare i pizzaioli.)
«Chi ha cotto queste uova?» domanda il cameriere. Uno dei cuochi, una donna, posa un tegame ed esce fuori a vedere.
«Io. Cosa c’è che non va?»
L’uomo ripete la sua lamentela, la donna prende la forchetta e assaggia le uova.
«Deve averle lasciate troppo tempo sul piatto» dice la cuoca «il piatto è diventato freddo.»
Molte mani si protendono a toccare il piatto e scoppia la discussione fino alla conclusione consensuale che il piatto è ancora un po’ caldo e che la donna deve invece aver stracotto le uova.
«Perché non le ha guardate?» chiede il cliente.
«Perché ho due fornelli e quattordici ordinazioni contemporaneamente!» ribatte la donna.
A questo punto alcuni clienti contenti del servizio intervengono dicendo che Ruth è una cuoca estremamente precisa e che ha sempre preparato le loro uova alla perfezione. Allora tutti i presenti si mettono a discutere a voce alta il problema dei carichi di lavoro di Ruth. (Nel frattempo, nuovi avventori affluiscono e si aggregano alla discussione: ora tutte le colazioni vengono servite fredde senza che nessuno se ne lamenti.) Qualcuno chiede a Ruth perché non ha chiesto aiuto quando è rimasta indietro, e lei, arrossendo, risponde, con uno sguardo risentito verso i colleghi, che quello è il suo lavoro e lo sa fare. Un altro cliente, che sembra conoscere Ruth, afferma di sapere che lei non avrebbe chiesto aiuto agli altri cuochi, che sono pure occupati, ma che non ci sarebbe stato niente di male ad ammettere che ogni tanto il carico di lavoro diventa eccessivo e ad accettare un aiuto se offerto.
Allora molti clienti intervengono dicendole che sarebbero felici di andare in cucina a dare una mano per qualche minuto. Ruth si mette a piangere, forse per la vergogna o per il sollievo. Un paio di clienti vanno in cucina, l’abbracciano, la aiutano; probabilmente lei lascia cadere lacrime salate sui primi piatti ordinati dopo la disputa, ma tutti se ne tornano contenti ai propri tavoli, con un’aria soddisfatta per l’andamento della vicenda, e il cliente che s’era lamentato mangia di gusto le sue nuove uova, dopo aver ringraziato ad alta voce e cordialmente Ruth che gliele ha portate di persona in una platea di sorrisi.
Piccoli psicodrammi come questo sembrano essere un fatto abituale nella vita ecotopiana. Hanno qualcosa di imbarazzante e di volgare, ma, per certi versi, sono anche piacevoli, e pare che attori e spettatori ne escano rafforzati.
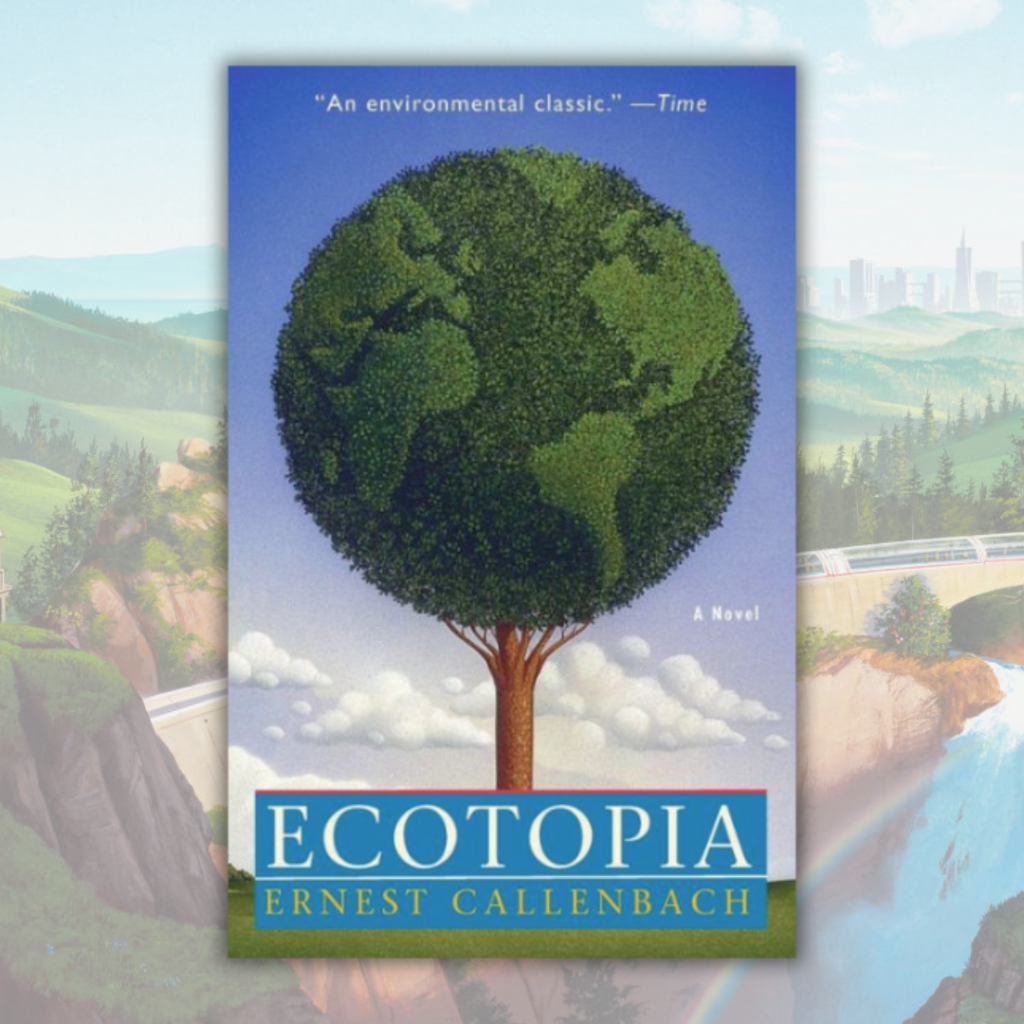
Questa è una scena da Ecotopia di Ernest Callenbach, un romanzo statunitense del 1975, oggi considerato a suo modo un precursore del genere solarpunk. Racconta di un futuro in cui una parte degli stati occidentali degli Stati Uniti ha portato a termine una sorta di rivoluzione ecologista interrompendo i rapporti con i restanti Stati Uniti. Nel 1999, diversi anni dopo l’indipendenza, a un giornalista statunitense è concesso per la prima volta di andare a visitare l’Ecotopia e redigere, insieme ai suoi personali diari di viaggio, una serie di reportage sulla società ecotopiana.
Tutto sommato, ci sentiamo di dire che Ecotopia è un romanzo invecchiato male, intriso di Guerra fredda, progressismo hippy, capitalismo, caccia sportiva, sguardo sessualizzante e soluzioni tecnologiche all’imperativo etico ecologico, il tutto problematizzato solo a tratti. Allo stesso tempo però accadono delle cose molto interessanti, per esempio questa:
Qui, l’impiegato di una biglietteria non tollera che gli si parli nel modo che mi è abituale: quello della stazione mi ha chiesto se lo avevo scambiato per un distributore automatico. Infatti, non ti dà proprio il biglietto se non t’intrattieni con lui come una persona reale, ed egli insiste per occuparsi di te, facendo domande, osservazioni alle quali s’aspetta una risposta sincera, e ti sgrida se non l’ottiene.
Questo è il modo in cui la rivoluzione ecotopiana si riflette nei rapporti sociali. Nelle riunioni politiche:
non ci sono né mozioni d’ordine, né votazioni, si assiste invece a una graduale discussione di pareri, ad antagonismi personali, e a una convergenza consensuale per approssimazioni successive su ciò che occorre fare.
Raggiunto il consenso, la gente si prende cura di calmare gli spiriti di quei militanti che hanno dovuto cedere del terreno affinché si raggiungesse l’accordo. Soltanto dopo che questo processo di composizione ha avuto luogo, si arriva a una formale ratifica delle decisioni prese: il solo atto questo, in quasi tre ore di riunione, che dia la sensazione della normale attività politica quale noi la conosciamo. […] D’altra parte, si deve pure riconoscere che gli ecotopiani amano queste riunioni: forse anche noi dovremmo imparare qualcosa da loro.
Con grande stupore del protagonista, sembra proprio che le persone in Ecotopia siano sempre “persone”.

Un’ora prima che arrivassimo al mare, Hugh [mio marito] si è fermato all’Hardee’s, un fast food, per farmi prendere un caffè. Eravamo in una cittadina piccola e triste, e a parte noi il ristorante era deserto. Appena oltre la porta c’era un albero di Natale sontuosamente addobbato in rosso e oro.
«Quanto tempo fa l’avete fatto?» ho chiesto alla donna di colore dietro il bancone.
Lei si è grattata i tatuaggi sull’avambraccio sinistro, delle iniziali che sembravano fatte in casa con un ago da cucito. «Boh, martedì scorso?» Si è girata verso il collega che stava pulendo la piastra di cottura. «Ti torna?»
«Sì, più o meno» ha risposto lui.
«Farete l’albero anche a casa?» ho chiesto. «L’avete già messo su?»
Sono le cose per cui Hugh diventa matto – “Cosa importa se ha già fatto l’albero?” –, ma dietro di me non c’era nessuno, ed ero sinceramente curioso.
«Per me è troppo presto» ha risposto lei. «I miei figli sono già lì che scalpitano, ma ancora non è finito il Ringraziamento.»
Gretchen [mia sorella] si è passata la mano sana tra i capelli finti che aveva in testa. «Giovedì farete il tacchino o avete optato per qualcos’altro?»
«Siete contenti, adesso?» ci ha chiesto Hugh quando infine siamo risaliti in macchina. «Vuoi tornare a chiedere cosa fanno a Capodanno o dici che possiamo andare?»
Gretchen ha appoggiato il braccio rotto sul bordo del finestrino. «Se pensa che noi siamo messi male, dovrebbe passare più tempo con Lisa.» [l’altra sorella]
«È vero» ho concordato. «Lisa è la migliore. L’anno scorso l’ho lasciata sola in uno Starbucks per un minuto e mezzo, e al ritorno la signora al banco le stava dicendo: “Il mio ginecologo mi ha detto la stessa cosa”.
Calypso di David Sedaris quanto di più diverso da Ecotopia. È una raccolta di 21 essay narrativi (“letterari”) uscita nel 2018 in forma unitaria. I testi raccontano in prima persona un pezzo della vita dell’autore e della sua famiglia di classe media statunitense. Anche con tutte le correzioni, le false memorie e le bugie che ogni autobiografia inevitabilmente contiene, resta una raccolta di non-fiction, è per questo che, secondo noi, vale la pena di affiancarlo a Ecotopia.
Sedaris e la sua famiglia hanno una peculiarità: spesso si mettono a parlare con dellɜ sconosciutɜ e, in brevissimo tempo, arrivano a raccontare e a farsi raccontare dettagli estremamente intimi e personali delle loro vite. Questi modi intraprendenti, invasivi dei confini personali, saltano all’occhio e irrita alcunɜ (come Hugh); a differenza di Ecotopia, qui nel mondo reale c’è chi reagisce bruscamente, quasi tuttɜ sono stupitɜ. Eppure la maggior parte delle persone, con più o meno resistenza, si convince a rispondere. Questa sembra essere in fondo la scommessa dell’autore: quando siamo interprellatɜ con “sincera curiosità”, anche se è fuori luogo, abbiamo tuttɜ voglia di rispondere.
Sedaris ignora lo stupore altrui, e con ostinazione incanala la conversazione in direzioni inattese e (nonostante quello che ne pensa suo marito) piuttosto interessanti. Tuttavia, la scelta di rendere questi incontri così inattesi e personali, sembra guidata da una postura più esistenziale o artistica che politica; non c’è alcuna etica ecotopiana, ma un interesse antropologico tutto sommato accettabile se si considera che Sedaris fa appunto lo scrittore. È un’attenuante, certo, ma da questo libro ci prendiamo il senso di possibilità, la sensazione che questa pratica sia immediatamente realizzabile, che possa essere sperimentata sulla nostra pelle e nella nostra vita quotidiana.
Uscire dai ruoli
Cos’hanno in comune queste due scene? Noi ci abbiamo letto un simile concentrarsi sulla questione della rottura dei ruoli sociali, con un significato che nel primo caso è espressamente politico, nel secondo esperienziale e sentimentale.
Ci sono diversi modi di pensare le società in termini di ruoli: alcuni più deterministici e funzionalisti, che pensano il “ruolo” di ciascunə nella società in termini della “funzione” che costəi ricopre come ingranaggio nel tutto organico; altri più incentrati sul senso di sé, ovvero sulla descrizione fenomenica di come ci comportiamo quando ci sentiamo investitɜ di un certo ruolo (per esempio tutta la letteratura che trae spunto dall’interazionismo in sociologia). Questi due estremi del continuum assomigliano ai modi in cui Callenbach e Sedaris pensano i ruoli: come una posizione fissa nella società (gerarchica) il primo, e come qualcosa che ci lega al decoro, al pudore, al senso di noi stessɜ, nel secondo. Intesi così, i ruoli sono l’obiettivo polemico dei due testi. La loro rottura non è teorica ma, al contrario, completamente agita dai personaggi sulla scena. Ecco cos’hanno in comune.
Sui ruoli
Nella nostra esperienza “avere un ruolo” ha la doppia conseguenza di sentirsene personalmente investitɜ e di essere riconosciutɜ dallɜ altrɜ come portatricɜ di quel ruolo, e pertanto legittimatɜ o interdettɜ dal fare determinate cose. Per esempio, ricoprirendo il ruolo di genitorə potremo/dovremo fare determinate cose (dovremo comportarci conformemente, rivolgerci ad altrɜ secondo quanto si aspettano da noi; potremo accedere a particolari spazi ecc.), e insieme non potremo/non dovremo farne determinate altre (come parlare o agire in un modo che ci faccia apparire inadeguatɜ al ruolo).
Fino a qui la comprensione dei ruoli si ferma al livello di segni e significati. Desideriamo però provare a complicare il rapporto tra chi fa l’azione e lo spazio circostante. Scendendo nel livello di astrazione, troviamo che i ruoli sono fatti certamente di parole, concetti, regole e aspettative condivise, ma anche di oggetti materiali che li fissano, predispongono i binari entro cui si svolge l’interazione e danno forma al mondo (come il bancone di formica della tavola calda e il grembiule della donna che ci lavora in Calypso).
L’istituzionalizzazione dei ruoli di cui parleremo tra poco, il loro “fissaggio” dentro la sfera delle pratiche e del sapere intersoggettivo, produce allo stesso tempo norme di comportamento e paesaggi. Le prime coinvolgono principalmente gli umani, a cui è riconosciuta la capacità seguire le regole, ma anche di eccederle con originalità (come fa Sedaris); mentre i secondi, i paesaggi, sono considerati essenzialmente non umani, guidati da “leggi di natura” secondo una logica meccanica.
Da un lato l'”immateriale” e dall’altro il “materiale”. Sarebbe superfluo specificarlo, ma dal momento che ci proponiamo di parlare di queer in una prospettiva materialista, dobbiamo rendere conto da subito delle due componenti dei ruoli, perché i gesti e le azioni a cui faremo riferimento quando parleremo di dissidentificazione agiscono necessariamente su entrambe le dimensioni.
Sull’identità
I ruoli hanno una componente performativa (ciò che facciamo in quanto qualcosa) e una componente identitaria (ciò che ci sentiamo in quanto qualcosa). Madri, operai, punk: ogni ruolo ci fa fare delle azioni, e allo stesso tempo ci rende qualcuno che è riconoscibile da noi stessɜ e dallɜ altrɜ. Quando interpretiamo quel qualcuno, tendiamo ad agire spontaneamente le azioni che associamo a quel ruolo. Detto altrimenti, tendiamo a cercare e a perpetuare una qualche coerenza tra il “sentirsi”, l’”essere riconosciutɜ” e il “fare”. L’oggetto delle nostra critica non è questa coerenza, ma l’istituzionalizzazione di questi tre aspetti, il loro fissarsi in un essere qualcosa.
Ad esempio, un ruolo di genere, diciamo un generico femminile occidentale contemporaneo, comprende delle azioni che noi e lɜ altrɜ riconosciamo come genderizzate. Le donne partoriscono, si truccano, fanno lavori di cura e molto altro. Ma da sole queste azioni sono azioni, non bastano a fare “qualcosa che si è”. Per diventarlo devono innanzitutto essere assunte come azioni-di-genere al punto da farci sentire di avere un genere quando le facciamo (o in quanto le facciamo). La cura dellɜ altrɜ è un emblema di femminilità, e tanto più performo la cura, quanto più la mia femminilità ne è rafforzata. In secondo luogo queste azioni “femminili” devono renderci quel genere a tutti gli effetti, ovvero sovrapporre “la mia femminilità” al mio intero essere, tingendo qualsiasi altra azione alla luce di un’identità principale, stabile, più vera e fondamentale, che è il mio essere donna.
Quest’ultimo passo è l’istituzionalizzazione, cioè la creazione di un’identità che è:
- reale, percepita e riconosciuta;
- multipla (posso essere donna e operaia);
- tendenzialmente fissa o perlomeno duratura;
- agente, nel senso che mi fa fare delle cose.
In questo esempio, essere una donna o un’operaia può occupare una parte consistente di ciò che “si fa” e “ci si percepisce” nella propria vita quotidiana. Ma l’assolutizzazione di questa esperienza e la sua fissazione in qualcosa che semplicemente “siamo” la rende qualitativamente superiore al fatto in sé di lavorare in fabbrica o truccarsi.
Quando un’esperienza diventa identità ci fissa al tempo e allo spazio in cui ci troviamo, rendendoci impossibile proiettarci altrove e in un altro tempo, comprendere o immaginare vite diverse, entrare speculativamente nei panni di un’altra persona1. L’identità ci fissa a noi stessɜ, è un filtro che si frappone tra noi e lɜ altrɜ, che inficia la nostra possibilità di comprensione e dialogo con l’alterità. Questo è il nostro principale obiettivo polemico, perché intendiamo il queer come qualcosa che liberi le possibilità di relazione, non che le limiti ulteriormente.
Una direzione
Un primo passo che vogliamo fare è mettere da parte il concetto di identità in favore di quello di esperienza. L’esperienza è qualcosa che ci forma, contribuisce a farci agire come agiamo e sentire quello che sentiamo, ma non corrisponde mai alla nostra interezza, è storico nel senso che si lega alla storia della nostra vita e alle nostre esperienze di vita, le sue conseguenze possono essere consistenti, ma anche modificarsi o esaurirsi nel tempo.
Un esempio che ci tocca da vicino è quello della transness. Per prendere parte al discorso sulle politiche trans* abbiamo bisogno di situarci, di essere riconosciutɜ come parte in causa. Abbiamo imparato che questo può essere fatto non alla luce delle nostre identità trans*, ma delle nostre esperienze trans*, di quelle parti di vissuto che ci accomunano ad altrɜ. Vogliamo imparare ad adottare questo punto di vista ogni volta che si corre il rischio, con le migliori intenzioni, di ricadere nell’identity politics.
Un secondo passo che vorremmo proporre verso la de-istituzionalizzazione dei ruoli è decisamente più materiale. Consiste nell’imparare collettivamente a prendersi cura degli spazi e dei momenti di rottura dei ruoli. Questo è quello che abbiamo chiamato dissidentificazione. Accenneremo ad alcune pratiche concrete che pensiamo in questa direzione. Ma prima di chiudere definitivamente con la teoria, sentiamo il bisogno di ricondurre queste istanze a una dimensione di lotta più ampia.
Una tradizione di lotte di dissidentificazione
Negli anni Sessanta il Giappone registrò una crescita tale da far sospettare che sarebbe emerso come il nuovo grande attore economico mondiale, accanto a Stati Uniti e blocco socialista. Per questa ragione, il 16 novembre 1962, il governo Ikeda si impegnò nella progettazione un nuovo aeroporto internazionale, che sarebbe sorto a est di Tokyo, a Narita, nella prefettura di Chiba.
La costruzione dell’aeroporto avrebbe comportato un cambiamento nel paesaggio e nella vita delle persone dell’area, che includeva la scomparsa di alcune comunità agricole. Nel 1966 nacque la Lega di Sanrizuka-Shibayama per l’opposizione alla costruzione dell’aeroporto di Narita, formata dalle opposizioni locali, con la guida dei partiti d’opposizione Socialista e Comunista. L’oggetto del contendere non era solo la distruzione delle aree agricole e delle comunità che le abitavano, ma l’ingiustizia procedurale che sottendeva: né gli enti locali, né la popolazione civile erano stati coinvolti in primo luogo nella decisione di costruire l’aeroporto, che ritenevano avrebbe avuto un impatto negativo sulle loro vite e sull’ambiente in cui vivevano.
Tra il 1966 e oggi, la Lega di Sanrizuka-Shibayama e altri gruppi hanno mobilitato circa 17mila persone, nel corso di azioni che hanno comportato occupazioni, riot e scontri con la polizia, in quelli che vengono chiamati Sanrizuka Struggle.
Il 27 aprile 1978, Michel Foucault tenne una conferenza a Tokyo. Il testo del suo intervento fu poi trascritto in un articolo intitolato La filosofia analitica della politica. Si legge:
Nella storia di Narita, che va avanti da anni e anni in Giappone, ritengo significativo che gli avversari o coloro che oppongono resistenza non sperino di spuntare maggiori vantaggi, facendo valere la legge o chiedendo degli indennizzi. Non si è voluto giocare il gioco, tradizionalmente organizzato e istituzionalizzato, dello Stato con le sue esigenze e dei cittadini con i loro diritti. Non si è voluto giocare il gioco in nessun modo; si impedisce al gioco di essere giocato.
[…] non c’è dubbio che, accettando qualcuna delle proposte ricevute, gli agricoltori di Narita avrebbero potuto trarre dei vantaggi tutt’altro che irrisori. Il loro rifiuto è dipeso dal fatto che non volevano saperne del potere che veniva esercitato su di loro. In questo caso, la scommessa non era economica, riguardava la modalità di esercizio del potere, il fatto che, in un modo o nell’altro, l’esproprio fosse deciso dall’alto: a questo potere arbitrario si è risposto con un’inversione violenta del potere.3
In effetti, Foucault riconduce questo tipo di politica a più ampie trasformazioni che stanno avvenendo nella società sua contemporanea. In Francia, ma anche altrove, il discorso politico inizia a interrogarsi su temi come la salute e la malattia, la legge e il carcere. E non lo fa prendendo parte al gioco democratico, per ottenere migliori condizioni per i malati, i carcerati (e forse i lavoratori4):
Ormai la cosa fondamentale non consiste più nel partecipare a questi giochi di potere, in modo da far rispettare al massimo la propria libertà o i propri diritti; questi giochi non sono più accettati. Non si tratta più di scontri all’interno dei giochi, ma di resistenze al gioco e di rifiuto del gioco stesso. È questo che caratterizza un buon numero di lotte e di battaglie.
In un saggio successivo5, tornava a osservare in modo ancora più analitico questa e altre opposizioni, come quella «al potere esercitato dagli uomini sulle donne, dai genitori sui figli, dalla psichiatria sul malato di mente, dalla medicina sulla popolazione, dall’amministrazione sul modo in cui la gente vive». Tracciava allora i contorni comuni di queste che definisce «lotte antiautoriarie»:
1. Si tratta di lotte «trasversali»; vale a dire che non sono circoscritte a un solo paese […] Non solo limitate a una particolare forma di governo economico o politico.
2. Il fine di queste lotte sono gli effetti di potere in quanto tali. A esempio, la professione medica non viene criticata in primo luogo perché è legata a interessi economici, ma perché viene esercitato un potere incontrollato sui corpi degli individui, sulla loro salute, sulla loro vita e sulla loro morte.
3. Sono lotte «immediate» per due ragioni. Attraverso queste lotte gli individui criticano le istanze di potere a loro più vicine, quelle che su di essi esercitano la loro azione. Gli individui non cercano il «nemico principale», ma il nemico immediato. […] Considerate rispetto a una scala teorica di spiegazione, […] si tratta di lotte anarchiche.
Ma sopratutto, le loro caratteristiche veramente salienti:
4. Si tratta di lotte che mettono in questione lo statuto dell’individuo: da un lato, asseriscono il diritto alla differenza e sottolineano tutto ciò che può rendere gli individui veramente tali. Dall’altro, attaccano tutto ciò che separa l’individuo, tutto ciò che recide i suoi legami con gli altri, lacera la vita comunitaria, costringe l’individuo a ripiegarsi su sé stesso e lo vincola in modo forzato alla sua propria identità. Queste lotte non sono esattamente a favore o contro «l’individuo», ma si oppongono piuttosto al «governo dell’individualizzazione».
5. Oppongono una resistenza agli effetti di potere che sono connessi al sapere, alla competenza e alla qualificazione: si tratta di lotte contro i privilegi del sapere. […]
6. Infine, tutte le lotte contemporanee ruotano attorno alla domanda: chi siamo? Esse rappresentano un rifiuto di quelle astrazioni costituite dalla violenza economica e ideologica dello Stato che ignora chi noi siamo individualmente, e sono anche un rifiuto della inquisizione scientifica o amministrativa che determina la nostra identità. Riassumendo, il principale obiettivo di queste lotte non è tanto di attaccare «questa o quella» istituzione di potere, o gruppi o élite, o classi, quanto piuttosto una forma o tecnica di potere.
Questa forma di potere viene esercitata sulla vita quotidiana immediata che classifica gli individui in categorie, li marca attraverso la loro propria individualità, li fissa alla loro identità, impone loro una legge di verità che essi devono riconoscere e che gli altri devono riconoscere in loro. È un tipo di potere che trasforma gli individui in soggetti.
Cogliamo alcune di queste caratteristiche in molte lotte a noi contemporanee6. Ma ci sembra che, tra le diverse istanze, siano quelle all’intersezione tra anarchismo e queer ad avvicinarsi di più a una esplicita rivendicazione di questi punti e alla sperimentazione di pratiche che vadano in direzione della destituzione di specifici poteri istituzionalizzati7.
Immaginarci in questa discendenza antiautoritaria, ci serve a mettere in luce che una dimensione collettiva della lotta è in linea di principio possibile, al di là del fatto che saremo in grado di crearla o che l’individualizzazione, la paura e il capitalismo avranno la meglio su di noi.
Dissidentificare, qui e ora
La dissidentificazione ci chiede di distruggere e creare
A differenza delle delle lotte antiautoritarie (almeno nell’analisi di Foucault), la dissidentificazione si dà in due parti, non distinte e successive: la violenza destituente e la prefigurazione costituente.
La rottura dei meccanismi di mantenimento dei ruoli istituzionalizzati può avvenire, come mostrano le due scene che abbiamo riportato prima, nel corso di una semplice conversazione, quando esponiamo parti di noi che normalmente lasceremmo altrove (sessualità, salario, vita familiare o politica… ), quando si rompe la divisione dei ruoli, mettendo in discussione lo statuto del lavoro (“il bigliettaio”) o riequilibrando le mansioni a partire dalla percezione incarnata (quella di “avere troppo lavoro” della cuoca ecotopiana). Ma la rottura avviene anche quando un gruppo blocca fisicamente l’espropriazione dei territori, rinunciando alla rappresentanza democratica che assegnerebbe a un soggetto politico il ruolo di cittadino che va rappresentato.
Non è solo una forma punk di opposizione al sociale, un atteggiamento sfidante o apertamente sovversivo. Accanto — intanto, nella lotta — c’è una fase ricostruente, capace di costruire rapporti sociali nuovi ed egualitari. La sfida della dissidentificazione è riconnettere la violenza destituente delle lotte collettive e l’utopia costituente nei rapporti personali. Da un lato ci chiede di far sì che le lotte antiautoritarie possono dialogare con le nostre esperienze sensoriali ed emotive. Dall’altro lato, armatɜ del motto femminista «il personale è politico», ci chiede di arricchire la politicità di quelle lotte, microfondandole nella pratica quotidiana.
“La passione per la distruzione è anche una passione creativa.”
Mikhail Bakunin
Dissidentificazione, come ogni negazione, contiene in sé anche ciò che nega; senza scomodare Freud, necessariamente il termine dissidentificazione deve rifarsi al concetto di identificazione. Rifarsi, certo, ma anche rifarlo, ovvero ricostruire quello che intendiamo per identificazione su basi diverse. Una creazione distruttrice che, invece di recidere nel conflitto i processi di soggettivazione8, li interrompe per creare nuove possibilità di interazione e costruzione reciproca.
La dissidentificazione ci chiede di essere drag
In una società gerarchica, fondata sullo sfruttamento e sulla violenza strutturale, le identità che si formano incorporano le ingiustizie, le ripropongono e contribuiscono a perpetrarle in modi spesso sottili, fanno sì che questo sistema sia interiorizzato e condiviso a qualche livello da tuttɜ noi.
Come il concetto di donna porta dentro di sé anche la minorizzazione storica che ha subito e ancora subisce, l’identità operaia può partecipare all’idea di valore capitalista, identificarsi col salario e con l’apparato industriale (si possono portare infinite critiche a ogni identità esistente, quante sono le ingiustizie contro cui lottiamo). La risposta è spesso di cercare di “depurare” le identità del loro contenuto repressivo/conservatore, rifondandole come rivoluzionare, in grado di sovvertire quegli stessi rapporti entro cui si sono definite. Noi, al contrario, sosteniamo che in un’ottica trasformativa abbiamo bisogno di “uscire dai ruoli”, o per meglio dire, uscire dalle identità.
L’ingiustizia è inscritta negli strumenti con cui ci costruiamo, siano essi parole, lavori di cura, paesaggi urbani, tacchi a spillo. Questi oggetti fanno sì che le nostre interazioni siano leggibili i termini di somiglianza e differenza da qualcosa, che abbiano senso. La dissidentificazione rompe uno o più di quei mezzi che mantengono le interazioni nel campo del senso.
Ma — e questo è cruciale — non pensa che esista una liberazione al di là di quegli oggetti. Come si diceva nel testo precedente, è un queer post-strutturalista, non crede in una verità soggettiva “al di sotto” delle determinazioni di potere e di genere. La dissidentificazione non ci chiede di liberarci di parole e tacchi a spillo, di rompere i rapporti con un mondo oppressivo per ritrovare una vera soggettività al di là del controllo e della repressione materiale.9 Ci chiede invece un uso drag, parodico ma non falso, degli oggetti con cui normalmente costruiamo l’identità sociale. Gli stessi strumenti che permettono di mantenere fisse le disparità di potere, vanno presi e usati in modi inattesi per ricostruirci in modi instabili10. A seconda di quanto marcate sono le differenze di potere in gioco, la dissidentificazione può essere più o meno carnevalesca, più o meno minacciosa (non si escludono a vicenda).
La dissidentificazione ci chiede di invischiarci e comprometterci
Prevedibilmente, e in modo abbastanza prosaico, rompere un ruolo è anche rompere le palle. O detto altrimenti, mettere a rischio un rapporto su cui facciamo affidamento.
In una relazione amorevole, condividere pensieri pesanti, solitamente relegati ai campi della patologia (l’autolesionismo, il percepirsi con più personalità, il desiderare altrɜ) ci mette in una posizione scomoda. L’opposizione diretta a una grande opera ci espone alla violenza dello stato. Interrompere un rapporto cliente-commerciante ci espone allo strano, al ridicolo (Posso usare sacchetti riutilizzabili? Oppure, potremmo mettere su un Gruppo di Acquisto Solidale? Un che?!). Cogliere le possibilità di incontro che sono già presenti nelle interazioni e ridurre attivamente le distanze con lɜ altrɜ è un’operazione che può riuscire o fallire.
Però nessuna dissidentificazione esiste mantenendo le distanze di sicurezza. Ci chiede, almeno per il tempo in cui ci sentiamo a nostro agio, di dismettere l’atteggiamento blasé, indifferente, con cui normalmente ci poniamo rispetto agli estranei – ci chiede di dismettere il concetto stesso di estranei. Ci spoglia dei guanti di velluto con cui maneggiamo i rapporti quando li pensiamo in un regime di scarsità. Non significa cercare attivamente l’insicurezza emotiva o materiale; al contrario, è cercare la sicurezza necessaria per mettere in discussione il modo in cui leggiamo un’interazione e l’identità che portiamo al suo interno. È darci gli strumenti per gestire le conseguenze della rottura pur non sapendo quali saranno. Credere nella mutua comprensione che si crea condividendo con una persona amata aspetti di noi stessɜ che non comprendiamo. Costruire comunità territoriali in grado di farsi carico materialmente ed emotivamente di uno scontro con l’autorità11.
La dissidentificazione ci chiede di vigilare, ovvero un’apologia del conflitto
Ovviamente le strutture di potere tendono a mantenersi nel tempo, se non nelle forme specifiche, nella differenza tra chi detiene un potere e chi no. Il potere economico ed epistemico è sempre distribuito secondo logiche patriarcali, anche se l’abbigliamento femminile è cambiato negli ultimi 70 anni. Il capitalismo sa gestire le sue crisi, incorporare le risposte ad esse, ricostruirsi.
La dissidentificazione ci chiede di vigilare affinché la rottura dei ruoli sia effettivamente tale, e non una ri-istituzionalizzazione diversa, che ci riporta al punto di partenza, una liberazione che produce il controllo deleuziano, in cui tutto è permesso ma costantemente governato. Lo strumento di questa vigilanza risiede per noi nel conflitto.
Il conflitto non è scontro: l’opposizione di due visioni o obiettivi messi l’uno contro l’altro, in cui uno vince e uno perde. Nello scontro leggiamo le parti attraverso dei ruoli totalizzanti che dividono in due il campo: noi e loro. Si basa su identità solide dei due fronti, costruite per darci gli attori da far scontrare. Ma se quelle identità iniziano a vacillare, se iniziamo a vederle come più sfaccettate, lo scontro perde di consistenza e ci lascia con qualcosa di molto più complesso e perturbante: il conflitto.
La lotta di classe, per esempio, può essere letta come uno scontro in cui una classe deve prevalere e l’altra soccombere. Allora può capitare di chiederci (come nelle assemblee politiche ecotopiane): che ne è di quellɜ che perdono, lɜ delusɜ e lɜ sconfittɜ? Vogliamo punirlɜ, convincerlɜ, coercirlɜ? Pensiamo che la loro prospettiva non abbia spazio nel mondo che intendiamo costruire? E se decidessero di ribellarsi? E se fossimo noi a perdere? Se queste domande ci preoccupano, o ci sembrano almeno rilevanti, forse dovremmo fare un passo indietro e mettere in dubbio l’idea che la soluzione politica si raggiunga con lo scontro. Serve un’altra soluzione, e trovarla non è facile.
Nel conflitto siamo costrettɜ a “rimanere a contatto con il problema”, a farci carico del fatto che tutto è conteso, ogni sguardo è posizionato e non c’è un modo semplice di decidere quale visione del mondo sia quella giusta da cui farci guidare. Nel conflitto scopriamo che noi e loro siamo parte della stessa danza, che anche noi siamo loro, e che insieme, noi e loro, siamo tuttɜ un po’ noi. Siamo chamatɜ in causa come persone, non come sostenitorɜ o simpatizzantɜ di una parte o di un’altra. Possiamo esserlo comunque, possiamo prendere posizione e rifiutare i compromessi, naturalmente. Ma il problema delle conseguenze del nostro rifiuto rimane anche una nostra responsabilità.
C’è una soluzione? Spesso c’è. Gettandoci nella mischia della complessità, a volte troviamo un tassello che ci era sfuggito, che può riportarci in uno stato di calma o riconfigurare le nostre relazioni reciproche in una nuova stabilità. Non si tratta necessariamente di una sintesi. E tuttavia, quando entriamo nel conflitto senza una rete di sicurezza, siamo sicurɜ che ne usciremo diversɜ, meno ingenuɜ, meno sicurɜ di noi stessɜ, meno legatɜ alle nostre identità.
Tornando alla dissidentificazione, una situazione destabilizzante e scomoda, come la rottura di un ruolo, può generare conflitto, che a sua volta ci può distanziare da noi stessɜ e dalle nostre identità. La dissidentificazione non è un modo per neutralizzare il conflitto, ma per riprodurlo.
Restare a contatto con il conflitto, imparare quali sono le sensazioni fisiche e i pensieri che ci suscita, come lo condividiamo con altrɜ e quali feedback riceviamo, sviluppare un’autoconsapevolezza come tecnologia del sé. Questo è, dal nostro punto di vista, un ottimo modo per sfuggire alla re-instituzionalizzazione. Se senti di stare nel conflitto, perennemente in dubbio e potenzialmente altro da te stessɜ, probabilmente stai dissidentificando.
Una propaganda del fatto queer
Dove stiamo andando
Letta così, dissidentificare (queering) diventa un modo diverso di porsi nel mondo. Ma con quali prospettive? Raggiunta una certa massa critica di azioni di dissidentificazione, queste non sono più leggibili come uno strappo alla norma. Essa produce esperienze e diventa il modo stesso in cui integriamo, praticando ed esperendo un continuo fluire di posture e ruoli che non permette di fissarli in identità istituzionalizzate, ma che preserva (esaspera?) la possibilità di comunicare.
Dovremo imparare a ricucire gli strappi, a praticare la cura, a superare le forme di comunicazione che consideriamo più “appropriate”, aprendoci a un campo più ampio di espressione, in modo da costruire sempre più conflitti e sempre meno scontri. Dovremo rendere, cioè, le continue uscite dai ruoli sempre più leggibili non come attacchi ma come scarti, spostamenti del baricentro del potere nelle nostre interazioni in modo che non si formi dominio.
Dei fini e dei mezzi
Tutto quell’insieme di gesti che abbiamo chiamato dissidentificazione (nei nostri esempi e molti altri) costituiscono una forma di propaganda del fatto queer.
Il punto fondamentale è che, a differenza di altre proposte di pratiche queer rivoluzionarie, non richiedono affatto che chi le fa sia “queer” (questa volta nel significato più diffuso di non-cis/eterosessuale o comunque non conforme al corpo e al desiderio dominanti). Un queer che riguarda solo la frocezza e la fluidità del genere non è abbastanza. La sessualità, la famiglia, la comunità e le relazioni più strette di cura e interdipendenza sono una parte del progetto queer, ma non lo esauriscono. L’istanza, da moltɜ avanzata ma da pochɜ presa sul serio, secondo cui il queer può essere una pratica rivoluzionaria, deve guardare a tutti i rapporti quotidiani, al modo in cui occupiamo lo spazio, a come ci sentiamo mentre abitiamo le relazioni — perché le relazioni possono (e devono, secondo noi) diventare il centro del nostro mondo nel sostituirsi al capitale e alla gestione eterodiretta dei corpi e delle scelte. E questo riguarda tuttɜ.
Nella pratica politica, “queer” è un verbo, non un aggettivo. Non siamo una comunità, una teoria o in un’identità; siamo gente che desidera queerizzare, lottare contro i ruoli, propri e altrui, e depotenziarli in modo più o meno eversivo.
Per noi è più facile: siamɜ le figliɜ bastardɜ di un movimento che, prima ancora che noi nascessimo, si era dissidentificato da genere e l’identità sessuale. Come persone non cis-eterosessuali abbiamo avuto accesso ai discorsi e all’immaginario sulla cura, ma il nostro sguardo va più lontano. Nella crisi dei rapporti sociali e materiali con tutto ciò che ci circonda, una crisi così profonda da renderci ormai quasi impossibile fare movimento a nostra volta, riteniamo che questo immaginario e gli strumenti per sperimentarlo debbano essere alla portata di chiunque, perché chiunque possa eventualmente dire: desidero praticare la cura12.
E così, in rapporti inattesi e non mediati, in cui possiamo finalmente chiedere aiuto, dare sicurezza, portare le nostre necessità, abbiamo deciso che non saranno le bombe a renderci liberɜ ma l’implosione delle nostre identità.
La nostra rivoluzione è la dissidentificazione universale.
Note
[1] m scrive: Alcuni anni fa vidi un film che raccontava delle miserie di una giovane donna della metà del XIX secolo. All’uscita dal cinema un amico (un uomo) disse che il film non gli era dispiaciuto, però si rendeva conto di non riuscire proprio a immedesimarsi in una donna. Si era aperto un dibattito sull’assurdità di questa condizione, e su come invece le donne della compagnia non avessero alcun problema a rivedersi nei protagonisti uomini. Il nostro amico se n’era tornato a casa con la consapevolezza di essere un discreto figlio della cultura patriarcale. Anni dopo mi rendo conto che la protagonista del film non era affatto una persona che, in quanto donna, attraversava tutta una serie di difficoltà, era invece essenzialmente una donna, l’essere una donna era la sua caratteristica principale e la matrice a cui doveva essere ricondotta ogni sua azione e decisione. Il nostro amico uomo avrebbe senz’altro potuto comprendere le sue miserie, proiettarvi le proprie, compatire lei e le altre donne vittime della Storia, ma difficilmente avrebbe potuto immedesimarsi in lei, diventare lei per qualche ora…
[3] M. Foucault, La filosofia analitica della politica, in “Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste.”, vol. 3 (1978-1985), a cura di A. Pandolfi, Feltrinelli, 1998, pp. 106-109
[4] Qualcosa di simile ci sembra di leggere nell’analisi che l’operaismo italiano fa della dissidenza non sindacalizzata dell’operaio-massa. Foucault non cita il movimento dei lavoratori, ma noi ci immaginiamo che non fosse impermeabile a questi cambiamenti.
[5] M. Foucault, Perché studiare il potere. La questione del soggetto, in H. Dreyfus, P. Rabinow, “La ricerca di Michel Foucault. Analitica della verità e storia del presente”, Ponte alle grazie, 1989
[6] Avremmo potuto facilmente sostituire la storia dell’aeroporto di Narita con la storia del movimento NoTav.
[7] Con Foucault e l’anarchismo contemporaneo, non intendiamo eliminare i rapporti di potere, ma il dominio basato sull’istituzionalizzazione dei rapporti di potere e la minaccia di coercizione.
[8] Con questo non stiamo comunque negando la potenzialità delle pratiche antisociali. Per una discussione: S. Grassi, Anarchismo Queer, ETS, 2013.
[9] Diciamo, con una finezza retorica, che l’idea di un sé liberato, che sia dallo Stato o dal condizionamento della sessualità borghese, che esiste completamente al di fuori della nostra esperienza e a cui dovremmo tendere in quanto identità libera e pura, reale in modo iperuranico, è l’identità più istituzionalizzata possibile.
[10] Riprendiamo ovviamente tutta la lezione butleriana sulla performance, ovvero la costruzione delle identità di genere attraverso il nostro agire, e la possibilità di sovvertire questa costruzione, vedi J. Butler, Questioni di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, Editori Laterza, 2017. Come abbiamo detto, dissidentificazione è una traduzione — con qualche spezia — e non una rifondazione del queer.
[11] Questo è quello che Comitato Invisibile chiama la comune, ovvero «una qualità del legame e una maniera d’essere nel mondo», un «rapporto comune», «il patto di affrontare insieme il mondo», «legarsi». Vedi: Comitato Invisibile, L’insurrezione che viene, Nero Edizioni, 2019, disponibile anche su www.porfidotorino.it
[12] Questo non sminuisce la necessità di spazi separatisti. I criteri di accesso alle singole relazioni di cura possono essere stabiliti solo da chi le fa, e da nessun altrɜ.
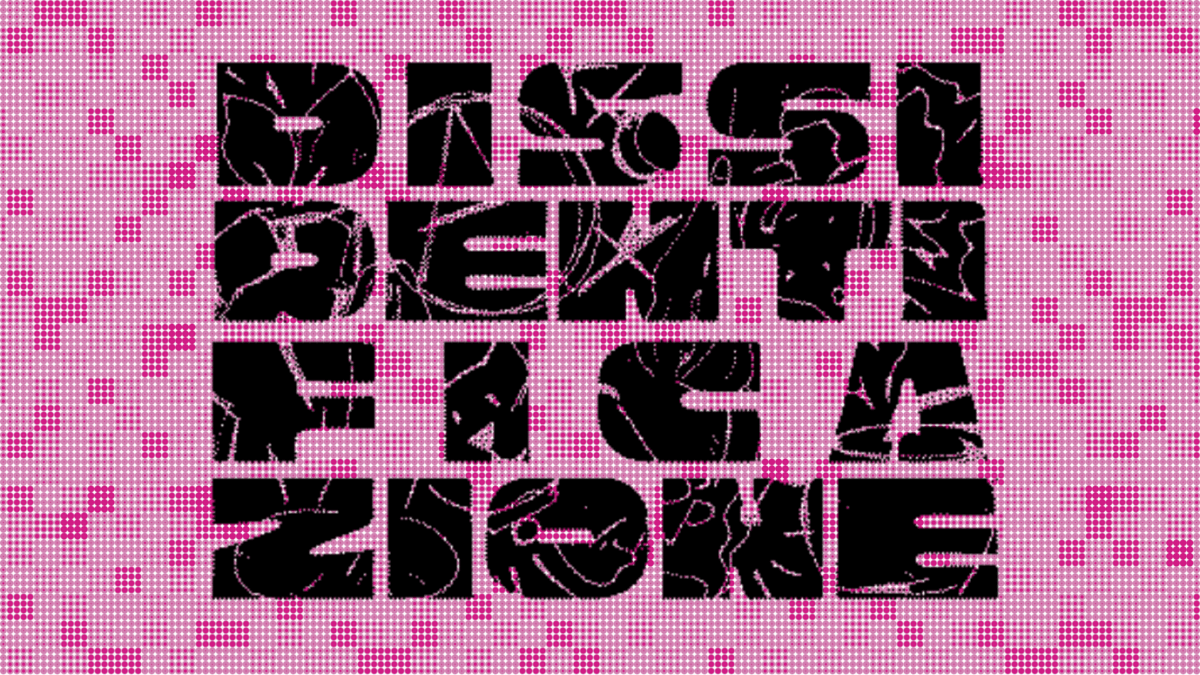
✉️ Ricevi la newsletter
📺 Entra nel canale Telegram